Pubblicato il
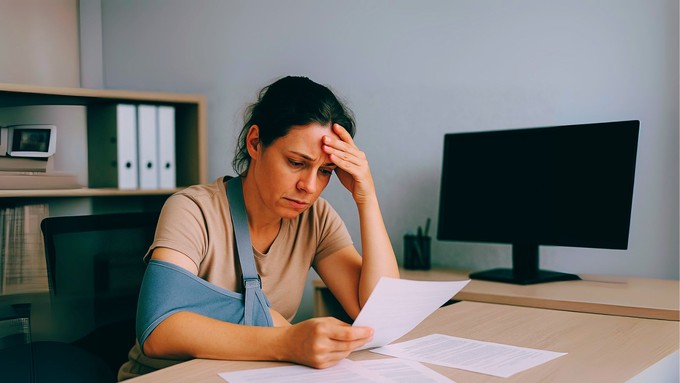
Quando una persona perde il lavoro a causa di un infortunio con postumi permanenti, ha sempre diritto al risarcimento per lucro cessante?
Inoltre, è necessario dimostrare di aver cercato attivamente un nuovo impiego per ottenere il danno patrimoniale?
Sulla questione è intervenuta la Cassazione con l'ordinanza n. 16604 del 20 giugno 2025.
La vicenda
Il caso riguarda una lavoratrice impiegata nelle pulizie che, dopo un incidente stradale, ha subito una frattura dell'omero.
L'assenza prolungata per convalescenza ha comportato il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Secondo la Corte d'appello, il danno patrimoniale era risarcibile solo per sei mesi, tempo stimato come sufficiente per cercare un nuovo lavoro.
Ma la Cassazione non è d'accordo.
I principi in materia
La Corte di Cassazione ha richiamato alcune regole fondamentali:
Il risarcimento deve coprire l’effettiva perdita economica subita dalla vittima (art. 1223 c.c.).
La liquidazione del danno può avvenire in via equitativa, cioè secondo buon senso e valutazione concreta del caso (art. 1226 c.c.).
Se la vittima aggrava il danno con una condotta colposa (come l’inerzia nel cercare lavoro), questo può incidere sul risarcimento, ma solo se viene eccepito dalla controparte (art. 1227, comma 2, c.c.).
Tutti, anche chi ha subito un infortunio, hanno il dovere costituzionale di cercare un’occupazione utile alla collettività (art. 4 Cost.).
La Corte ha poi chiarito tre principi di diritto:
Il giudice deve prima accertare se c'è stata una perdita effettiva della capacità lavorativa e solo dopo valutare se la vittima ha aggravato il danno.
Il risarcimento non può essere escluso solo perché la vittima non ha cercato un nuovo impiego.
Non si può applicare automaticamente una percentuale di invalidità al reddito: serve un accertamento concreto.
La decisione della Corte
Nel caso di specie:
La vittima perde il lavoro a causa delle lesioni.
I postumi permanenti limitano l'articolazione della spalla sinistra.
Il giudice di appello ha subordinato il risarcimento alla prova di aver cercato un nuovo impiego.
La Cassazione censura questo ragionamento: prima si accerta il danno, poi si valuta se e quanto il danneggiato poteva reimpiegare le proprie forze industri. E se la vittima non ha più la capacità di lavorare, non serve nemmeno chiedersi se abbia cercato lavoro.
Inoltre, la Corte precisa che non si può calcolare il danno moltiplicando il reddito perso per una percentuale medica di incapacità lavorativa specifica. Il danno va provato in concreto, valutando la compatibilità tra i postumi e le mansioni precedenti, e gli effetti sul reddito.
Cosa ci portiamo a casa?
La Corte ribadisce che:
Il danno patrimoniale non si presume, ma si accerta in base al reddito realmente perduto.
Il danneggiato non deve provare la vana ricerca di lavoro prima che sia accertata la perdita di capacità lavorativa.
La riduzione del risarcimento può avvenire solo dopo, se emerge una condotta colposa (art. 1227 c.c.).
Quindi, no, non basta dire "non hai cercato lavoro" per negare il danno. Prima si verifica se la persona può ancora lavorare, poi si valuta il danno.
Cassazione civile sez. III, ordinanza 20/06/2025, (ud. 18/03/2025), n. 16604
Il fatto.
Nel 2014 Me.Ja.rimase vittima d'un sinistro stradale che le provocò, tra le altre lesioni, una frattura dell'omero. Si assentò dal lavoro ed il datore di lavoro la licenziò per superamento del periodo di comporto contrattualmente previsto.
Nel 2017 Me.Ja.convenne dinanzi al Tribunale di Milano la persona indicata come responsabile del sinistro (Fu.Ba.) ed il suo assicuratore della r.c.a. Unipolsai Spa chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
Dedusse, tra l'altro, di lavorare alle dipendenze di una ditta di pulizie; che a causa del protrarsi della convalescenza superò il periodo di comporto e fu licenziata; che a causa dei postumi permanenti (limitazione articolare dell'arto superiore sinistro) non poteva più attendere al medesimo lavoro svolto prima dell'infortunio.
Domandò, di conseguenza, il risarcimento del danno da lucro cessante rappresentato sia dalla perdita del lavoro svolto in precedenza, sia dalla ridotta possibilità di trovare un lavoro in futuro.
2. Il giudizio di merito.
Con sentenza 1 marzo 2021 n. 1742 il Tribunale di Milano - per quanto qui rileva - rigettò la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. Il Tribunale ritenne che:
il licenziamento non fu conseguenza del sinistro, in quanto l'infortunio provocò una invalidità temporanea di 220 giorni, inferiore al periodo di comporto (12 mesi); il licenziamento avvenne sol perché la lavoratrice aveva già fruito, prima del sinistro, di 230 giorni di congedo per malattia;
l'attrice, in violazione dell'obbligo di non aggravare il danno, non aveva chiesto al datore di lavoro.come le sarebbe spettato - un periodo di aspettativa non retribuita di quattro mesi ai fini della conservazione del posto di lavoro;
non vi era prova che, a causa dei postumi residuati all'infortunio, l'attrice non potesse trovare altri lavori equivalenti a quello perduto. La sentenza fu appellata da.Me.Ja.
3. Con sentenza 24.3.2022 n. 1003 la Corte d'Appello di Milano accolse in parte il gravame.
Il giudice di secondo grado ritenne che:
il licenziamento fu causato dall'infortunio;
tuttavia dopo il licenziamento la vittima non risultava essersi attivata per cercare una nuova occupazione;
il danno patrimoniale causato dal sinistro doveva perciò liquidarsi in via equitativa in una somma pari agli stipendi perduti tra il momento del licenziamento e quello in cui, se la vittima si fosse diligentemente attivata, avrebbe presumibilmente trovato una nuova occupazione: periodo stimato dalla Corte d'Appello in sei mesi.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Me.Ja.con ricorso fondato su tre motivi. La UnipolSai ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sull'ammissibilità del primo motivo di ricorso.
Col primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3, c.p.c., la violazione di undici diverse disposizioni di legge (cinque norme costituzionali, cinque articoli del codice civile, un articolo del codice delle assicurazioni).
1.1. Sebbene il motivo sia formalmente unitario, in esso vengono frammiste plurime e differenti censure.
Reputa tuttavia il Collegio che la confusiva esposizione del primo motivo di ricorso nel caso di specie non ne pregiudichi l'ammissibilità. Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che nell'interpretazione degli atti di impugnazione, quando si tratti di valutarne la chiarezza ai fini dell'ammissibilità, vanno conciliati due princìpi:
a) da un lato, quello di parità delle parti, che sarebbe vulnerato se il giudice dell'impugnazione ricercasse da sé, a prescindere dalle deduzioni di parte, gli errori eventualmente contenuti nella sentenza impugnata;
b) dall'altro, il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che vieta i formalismi eccessivi e quelli inutili ed impone, nel caso in cui un atto processuale sia suscettibile di interpretazioni differenti, di privilegiare l'interpretazione e la qualificazione che consentano di pervenire ad una decisione piena sul merito, rispetto all'interpretazione che conduca ad un giudizio di inammissibilità.
1.2. Il coordinamento tra questi princìpi deve avvenire ritenendo ammissibile il ricorso per cassazione se, e nella misura in cui, le censure proposte dal ricorrente, per quanto esposte in modo confusivo, possano comunque essere chiaramente individuate attraverso l'interpretazione utile dell'atto (così, da ultimo, Cass. 13/3/2025 n. 6653; nello stesso senso, ex multis, Cass. 6483/25 dell'11/3/2025; Cass. 5607/25 del 3/3/2025; Cass. 4955/25 del 25/2/2025; tutte queste decisioni richiamano i princìpi stabiliti, in subiecta materia, dalla Corte EDU con la sentenza 15/9/2016, Trevisanato c. Italia, in causa 32610/07).
1.3. Nel caso di specie ritiene il Collegio che nel primo motivo di ricorso siano ravvisabili quattro distinte censure, esposte rispettivamente alle pp. 8, 9, 11 e ss. e 13 del ricorso.
2. Sulla denuncia di omesso esame del fatto.
Con una prima censura (p. 8 del ricorso) la ricorrente deduce che la Corte d'Appello avrebbe "omesso di considerare due circostanze di fatto": da un lato, il licenziamento della vittima, dall'altro la sua perdurante condizione di disoccupata.
Tali circostanze secondo la ricorrente sarebbero decisive perché, se fossero state esaminate, la sua domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante si sarebbe dovuta accogliere in misura maggiore (la ricorrente mostra dunque implicitamente di ritenere che, una volta provate tali circostanze, null'altro dovesse dimostrare perché i convenuti fossero condannati a risarcirle il danno da lucro cessante).
2.1. La censura va qualificata ex officio come denuncia di omesso esame di fatti decisivi.
Essa è manifestamente infondata. Infatti le due suddette circostanze non sono state affatto trascurate dalla Corte d'Appello.
Quanto al licenziamento, esso è stato così poco trascurato dalla Corte, che anzi ha costituito il motivo per il quale il gravame è stato accolto. Quanto alla perdita della retribuzione, la Corte d'Appello lungi dal negarla l'ha ammessa (p. 16 della sentenza).
3. Sull'onere della prova.
Con una seconda censura (illustrata da p. 9, penultimo capoverso, a p. 11 del ricorso) la ricorrente formula una tesi che - depurata del disordine logico con cui è illustrata si può così riassumere:
il giudice di merito ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita permanente della capacità di produrre reddito, osservando che per ottenere il risarcimento del suddetto danno la vittima "avrebbe dovuto fornire prova, anche in forma documentale, di aver congruamente tentato di immettersi nel mercato del lavoro, svolgendo le relative ricerche, inviando il proprio curriculum o iscrivendosi presso il competente ufficio di collocamento. Solamente ove detta fase di ricerca avesse avuto quale esito l'assenza di offerte di lavoro ovvero offerte economicamente deteriori rispetto alla precedente occupazione, l'appellante avrebbe avuto diritto alla liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa specifica";
questa statuizione osserva la ricorrente sarebbe giuridicamente erronea sotto tre aspetti:
a) perché sarebbe "diabolica" la prova di un fatto negativo (non avere trovato altra occupazione), "a maggior ragione in considerazione del fatto che è stato offerto di provare per testi" la grave limitazione articolare alla spalla (trattavasi comunque della spalla sinistra, circostanza non riferita nel ricorso; non è dato sapere si tratti di soggetto destrimane);
b) perché una volta dimostrata dalla vittima di lesioni personali la perdita del posto di lavoro in conseguenza dei postumi null'altro dovrebbe dimostrare per ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante;
c) perché nessuna norma subordina il risarcimento del danno da lucro cessante alla prova che la vittima abbia vanamente cercato un nuovo lavoro.
3.1. Le prime due deduzioni appena riassunte sono erronee in punto di diritto; la terza è invece fondata.
4. Sull'ammissibilità della prova negativa.
La ricorrente erra nel sostenere che sia "diabolica" la prova d'un fatto negativo.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare, in qualunque modo, che un fatto non sia accaduto o non esista (Sez. 5 -, Sentenza n. 19171 del 17/07/2019; Sez. 3, Sentenza n. 14854 del 13/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 384 del 11/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 5427 del 15/04/2002). Così, ad esempio, non sarebbe inibito provare per testimoni che la cupola di San Pietro non è crollata; ovvero che il Tevere non è asciutto (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35146 del 18.11.2021).
5. Sulla prova del danno da perdita del lavoro.
La ricorrente erra, altresì, nel sostenere che la dimostrata perdita del posto di lavoro in conseguenza di lesioni personali costituisca di per sé prova dell'esistenza d'un danno patrimoniale, senza che sia necessaria alcun'altra indagine.
I postumi permanenti d'un infortunio possono provocare la perdita del lavoro e del reddito che da esso la vittima ricavava, ma non anche e necessariamente la possibilità di impiegare proficuamente in altro modo le proprie capacità di lavoro.
Ricorre in quest'ultimo caso l'ipotesi della "perdita di forze industri con possibilità di reimpiego", nota alla dottrina sin dall'ultimo quarto del XVIII sec..
La possibilità di reimpiego delle energie lavorative residue è circostanza di cui è doveroso tenere conto nella liquidazione del danno da lucro cessante: sia perché la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. impone di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto; sia perché l'art. 4, secondo periodo, della Costituzione, non consente che chi possieda forze industri passi le giornate senza far nulla.
Anche gli invalidi non del tutto inabili al lavoro hanno il dovere giuridico di cercarsi un'occupazione, e tale dovere è civilisticamente rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c. (Cass. Sez. 3, 21/04/2010, n. 9444, la quale ha cassato con rinvio la decisione con cui era stato liquidato il danno patrimoniale ad un soggetto che aveva perduto l'uso di una gamba e di un occhio, senza accertare se ed in che misura il danneggiato potesse porre riparo al danno subìto, dedicandosi ad altra attività remunerativa).
5.1. Alla luce dei princìpi appena esposti vanno prese le distanze dall'isolato precedente di questa Corte, nel quale si reputò "irrilevante", ai fini della stima del danno patrimoniale da perdita del reddito in conseguenza d'un infortunio, la circostanza che la vittima, pur avendo perso il lavoro, non avesse perso la capacità di procacciarsene un altro confacente alle sue attitudini.
In tal senso si espresse in passato Cass. Sez. 3, 22/02/2002, n. 2589, in base all'assunto che, quando il consulente medico legale nominato dall'ufficio accerti la capacità della perdita di "capacità lavorativa specifica", "il giudizio (sul danno) è stato già compiuto dal medico legale" e null'altro il danneggiato dovrebbe dimostrare.
Questo principio tuttavia non può essere condiviso per due ragioni.
5.2. In primo luogo perché il giudizio sull'esistenza del danno spetta al giudice, non al medico legale. A quest'ultimo potrà domandarsi, a tutto concedere, un giudizio di compatibilità tra i postumi permanenti e la
prosecuzione del lavoro, ma non certo un giudizio sull'esistenza e sulla risarcibilità del danno da lucro cessante. Né è ammissibile che, ritenuta esistente dal medico legale una "incapacità lavorativa", il giudice debba attenersi a questo ipse dixit e null'altro il danneggiato debba dimostrare, come non condivisibilmente ritenuto da Cass. 2589/02, già ricordata.
5.3. In secondo luogo perché la perdita della capacità di lavoro è la possibile causa d'un danno, ma non il danno. Quest'ultimo consisterà nella effettiva riduzione delle entrate della vittima, la quale non è necessaria ed indefettibile conseguenza dell'esistenza di postumi permanenti.
Il danno da lucro cessante va valutato in concreto e non in astratto, sicché l'esistenza di postumi permanenti di qualunque tipo non giustifica la pretesa al risarcimento del danno, se essi non hanno determinato in concreto una perdita del reddito, certa o almeno probabile.
5.4. Resta da aggiungere che esula dal presente giudizio di legittimità stabilire:
a) se la Corte d'Appello abbia inammissibilmente rilevato d'ufficio l'eccezione di colposo aggravamento del danno, di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c. (eccezione non rilevabile d'ufficio);
b) quale rilievo abbia, ai fini della correttezza della decisione, la circostanza che la Corte d'Appello abbia rigettato le prove testimoniali richieste dalla parte danneggiata.
Nessuna di tali questioni infatti ha formato oggetto di un motivo di ricorso per cassazione sufficientemente chiaro e preciso. La ricorrente, in particolare, si è limitata a dedurre di avere chiesto l'ammissione di una prova per testi "che la Corte d'Appello ha ritenuto di non ammettere", senza formulare censure avverso tale statuizione (p. 10 del ricorso).
6. Sulla liquidazione del danno da perdita del lavoro, ma con possibilità di reimpiego.
E' fondata invece la censura qui in esame, nella parte in cui sostiene che la vittima di lesioni personali, al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita del lavoro, non ha l'onere di provare di avere vanamente cercato un nuovo lavoro.
La sentenza impugnata ha rigettato il motivo di impugnazione con cui l'appellante domandava il risarcimento del danno da perdita della capacità di lavoro affermando che, per ottenere tale risarcimento, la vittima "avrebbe dovuto fornire prova, anche in forma documentale, di aver congruamente tentato di immettersi nel mercato del lavoro, svolgendo le relative ricerche, inviando il proprio curriculum o iscrivendosi presso il competente ufficio di collocamento. Solamente ove detta fase di ricerca avesse avuto quale esito l'assenza di offerte di lavoro ovvero offerte economicamente deteriori rispetto alla precedente occupazione, l'appellante avrebbe avuto diritto alla liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa specifica". Questa statuizione, nella sua assolutezza, non è condivisibile sul piano della logica, ed è comunque erronea sul piano del diritto.
6.1. Sul piano della logica, la lesione della salute sofferta da chi al momento dell'infortunio già godeva d'un reddito da lavoro può provocare tre tipi di conseguenze:
a) la vittima conserva il lavoro ed il livello di reddito, ma lavora con maggior pena: questo danno ha natura non patrimoniale e costituisce una circostanza di c.d. personalizzazione del risarcimento del danno biologico;
b) la vittima conserva il lavoro, ma vede ridursi il reddito (ad es., per la forzosa riduzione delle ore dedicate al lavoro o per la perdita di capacità competitiva): questo danno ha natura patrimoniale e si liquida capitalizzando il reddito perduto dalla vittima;
c) la vittima perde il lavoro e, con esso, il reddito che quel lavoro procacciava: anche questo danno ha natura patrimoniale e si liquida:
c') capitalizzando il reddito perduto dalla vittima; c'') variando il risultato in aumento o diminuzione per tenere conto delle circostanze del caso concreto, ed in particolare aumentando il
reddito da porre a base del calcolo per tenere conto degli aumenti futuri che sarebbero stati plausibili e verosimili; nonché riducendo il reddito da porre a base del calcolo, se la vittima pur avendo perduto il proprio lavoro, potrà utilmente reimpiegare le proprie capacità in altro lavoro, quand'anche meno remunerativo.
6.1.1. Pertanto nell'ipotesi sub (c) delle due l'una:
se la vittima, a guarigione avvenuta, ha visto ridotta ma non esclusa del tutto la sua capacità di occuparsi in un lavoro remunerativo, la circostanza che non abbia per propria negligenza cercato un nuovo lavoro potrà comportare la riduzione in via equitativa del risarcimento, ma non la sua totale esclusione;
se la vittima non ha conservato forze industri, a fortiori sarà superfluo esigere da essa la prova di avere vanamente cercato un altro lavoro.
Il reddito perduto è infatti il minuendo del danno da liquidare, mentre il reddito ancora potenzialmente ricavabile dalle residue forze industri è il sottrattore del danno da liquidare.
Dunque è illogico pretendere dal danneggiato la prova della ricerca d'un nuovo lavoro (prova necessaria per stabilire il sottrattore), se prima non si sia stabilito in concreto l'esistenza e l'ammontare del danno (il minuendo). La Corte territoriale pertanto ha violato gli artt. 1223 e 2056 c.c. in quanto, pur avendo accertato che Me.Ja.a causa dei postumi ha perduto il lavoro, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale senza previamente stabilire se i postumi del sinistro impediscano, ed in che misura, la prosecuzione dell'attività di addetta alle pulizie o lo svolgimento di lavori analoghi.
6.2. Anche sul piano del diritto la statuizione della sentenza impugnata trascritta al precedente par. 6 contiene un errore.
Tale errore è consistito nel subordinare alla mancata dimostrazione delle vane ricerche d'un nuovo lavoro non già la riduzione equitativa del risarcimento, ma addirittura l'esclusione totale del risarcimento del lucro cessante futuro. Nella liquidazione del danno di cui si discorre, infatti, i passaggi logici demandati al giudice di merito sono tre: a) dapprima occorre accertare se la vittima ha perso in tutto od in parte la capacità di svolgere il proprio lavoro; b) quindi occorre accertare se la vittima ha conservato forze industri per svolgere un altro lavoro; c) infine occorre capitalizzare il reddito perduto e sottrarre da esso il presumibile reddito ancora realizzabile con la residua capacità di lavoro della vittima.
La sentenza impugnata invece, senza accertare innanzitutto se i postumi permanenti impedissero alla vittima il lavoro di addetta alle pulizie, ha rigettato la domanda ritenendo che per prima cosa la vittima avesse l'onere di provare l'avvenuta e vana ricerca d'un nuovo lavoro. Così giudicando, la Corte d'Appello ha invertito l'ordine logico degli accertamenti da compiere, in quanto l'eventuale aggravamento colposo del danno, ex art. 1227, secondo comma, c.c., è un posterius rispetto all'accertamento dell'esistenza del danno ed alla sua entità (ed è subordinato all'eccezione di parte, sebbene come già detto nel caso di specie il ricorso non solleva il tema della rilevabilità ex officio).
6.3. La seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso va dunque accolta nei limiti sopra indicati, in applicazione dei seguenti princìpi di diritto:
"Ogni persona, anche se disabile, ha il dovere ex art. 4 Cost. di attivarsi per trovare un'occupazione. Pertanto nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, provocata da lesioni personali, è doveroso tenere conto della possibilità per il danneggiato di reimpiegare le residue forze industri in altro lavoro confacente alle sue attitudini".
"Chi ha perduto il lavoro in conseguenza d'un infortunio, ma non si attivi per cercarne un altro confacente e compatibile con le sue condizioni di salute,
tiene una condotta aggravativa del danno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., della quale il giudice deve tenere conto, se ricorrano tutti i presupposti sostanziali (la condotta colposa della vittima; il nesso di causa tra colpa della vittima ed aggravamento del danno) e processuali (l'eccezione di parte) richiesti dalla suddetta norma".
"Nella liquidazione del danno da perdita del reddito in conseguenza di lesioni personali, il giudice di merito deve dapprima accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza, e solo dopo procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze industri. Non è invece consentito rigettare la domanda senza compiere il suddetto accertamento, sol perché la vittima non abbia dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro".
7. Sulla nozione di "incapacità lavorativa specifica" e sui limiti degli accertamenti esigibili dal medico-legale.
Con una terza censura (pp. 12-13 del ricorso) la ricorrente formula una tesi che può così riassumersi: la sentenza impugnata sarebbe "iniqua" perché ha liquidato il danno patrimoniale da perdita del reddito in misura pari ai soli stipendi non percepiti dalla vittima nel semestre successivo al licenziamento, trascurando di considerare che:
il consulente tecnico d'ufficio, con valutazione recepita dal Tribunale, aveva accertato che l'infortunio aveva provocato una "incapacità lavorativa specifica del 25%";
la vittima non aveva mai svolto altro lavoro che quello di addetta alle pulizie;
i postumi lasciati dall'infortunio impedivano lo svolgimento di questa attività.
7.1. La censura non resta assorbita dal parziale accoglimento del ricorso, nei termini di cui si è detto nei parr. precedenti.
Una cosa, infatti, è stabilire se nella liquidazione del danno da perdita del lavoro debba tenersi conto della possibilità di reimpiego; altra cosa è stabilire il criterio col quale debba essere monetizzato il danno in esame.
7.2. Anche questa terza censura è fondata solo in parte.
La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità di lavoro osservando che "seppur la CTU abbia valutato un'incidenza negativa del 25% sulla capacità lavorativa specifica, la sig.ra Me.Ja.ha mancato di provare di essere impossibilitata a svolgere attività confacenti alla propria occupazione precedente, che fossero in grado di garantirle un reddito pari a quello che percepiva come operaia con mansioni di addetta alle pulizie".
La ricorrente ha censurato tale statuizione sostenendo:
che esiste in iure un pregiudizio patrimoniale definibile "incapacità lavorativa specifica";
che esso sia quantificabile in misura percentuale; che, una volta ritenuta sussistente dal medico legale la suddetta "incapacità lavorativa specifica" nella misura del 25%, ne debba seguire di necessità il giudizio di esistenza del danno patrimoniale.
7.3. Che a determinati postumi permanenti corrisponda una incapacità lavorativa specifica il cui pregiudizio sia stimabile in punti percentuali da parte del medico legale è affermazione erronea in punto di diritto, sicché il motivo in questa parte è infondato.
Altrettanto erronea, però, è la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la vittima d'un infortunio, per essere risarcita del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro, dovrebbe dimostrare di non potere svolgere un lavoro che le garantisca un reddito "almeno pari" a quello perduto: una sorta di regola dell' "all or nothing".
Nei parr. che seguono si esporranno le ragioni di quanto appena detto; tuttavia, poiché in subiecta materia la giurisprudenza di questa Corte ha espresso in passato opinioni non sempre coincidenti, reputa opportuno il Collegio
richiamare brevemente i princìpi che debbono presiedere alla liquidazione del danno da perdita del reddito conseguente a lesioni personali.
7.4. (A) Il danno e la sua causa.
Per risalente tradizione viene definita "incapacità lavorativa specifica" l'impossibilità totale o parziale, per la vittima di lesioni personali, di poter proseguire il lavoro svolto prima dell'infortunio (Cass. Sez. 3, 13/07/1964, n. 1870).
Trattasi di uno dei tanti concetti di matrice ottocentesca, ripetuti come mantra e senza più alcun approfondimento né condivisione di consenso sul loro esatto significato, che ancora allignano nel terreno del danno alla persona. L'impossibilità di proseguire il proprio lavoro, infatti, non è il danno: è la causa del danno. Non esiste una "capacità lavorativa" teorica ed astratta, che possa accertarsi in vitro a prescindere dalle sue conseguenze. Se l'infortunio colpisse una persona che abbia un reddito, delle due l'una: o la vittima dimostra di avere perduto il proprio reddito (in atto od in potenza, passato o futuro che sia), oppure no.
Nel primo caso la vittima avrà diritto ad essere risarcita a prescindere da qualsiasi giudizio sulla sussistenza d'una "incapacità lavorativa specifica"; nel secondo caso non avrà diritto ad essere risarcita, a nulla rilevando che il medico legale abbia ritenuto di ravvisare una "riduzione della capacità lavorativa".
Tali princìpi da tempo sono stati affermati da questa Corte, a partire almeno da Cass. Sez. 3, 18/05/1999, n. 4801, nella cui motivazione si stabilì (par. 4.2) che è risarcibile come lucro cessante il danno da riduzione del reddito (presente o futuro), "e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica", principio in seguito più volte ribadito (ex aliis, da Sez. 3, Sentenza n. 9048 del 12/04/2018, par. 4.3; Sez. 3, Sentenza n. 123 dell' 8/01/ 2016).
Da quanto appena esposto consegue che l'allegazione della ricorrente, secondo cui erroneamente la Corte d'Appello avrebbe rigettato la domanda di danno nonostante il medico legale avesse accertato una "incapacità lavorativa specifica del 25%", è doppiamente erronea:
a) sia perché l'incapacità di svolgere il proprio lavoro non è misurabile in punti percentuali;
b) sia perché il danno da lucro cessante va apprezzato in concreto in base al suo effetto (il reddito perduto o che presumibilmente sarà perduto), non in astratto in base alla sua causa (la perdita della capacità di lavoro).
7.6. Sotto il primo profilo, la pretesa di liquidare il danno da lucro cessante moltiplicando il reddito della vittima per una percentuale di "incapacità lavorativa specifica", immancabilmente rimessa al giudizio (se non, per quanto si dirà, addirittura all'arbitrio) del medico legale, è operazione giuridicamente, concettualmente e medicolegalmente erronea per tre motivi.
7.6.1. Il suddetto criterio liquidativo in primo luogo è erroneo perché al consulente tecnico medico-legale può chiedersi di indicare i postumi permanenti, precisando se essi impediscano in tutto od in parte la prestazione lavorativa; se la rendano più difficoltosa e sotto quale aspetto (forza, resistenza, concentrazione, perizia manuale).
Non è invece consentito demandare al medico legale un giudizio di tipo giuridico sull'esistenza del danno patrimoniale da lucro cessante, in quanto si tratterebbe d'una valutazione riservata al giudice e che travalica lo specifico settore di competenza del medico legale.
E però, nella sostanza, il criterio di liquidazione del danno patrimoniale consistente nel moltiplicare il reddito antesinistro per la percentuale di "incapacità lavorativa specifica", e capitalizzare il risultato (c.d. criterio di liquidazione "in abstracto") ha per effetto proprio lo spostamento del centro decisionale dal giudice al medico legale.
Il danno patrimoniale infatti attraverso l'adozione di questo criterio finisce per essere liquidato senza alcun accertamento in concreto sulle variazioni del
reddito della vittima prima e dopo il sinistro, ma semplicemente capitalizzando (non il reddito perduto, ma) una percentuale di reddito corrispondente alla percentuale di "incapacità lavorativa specifica", percentuale che per quanto si dirà altro non è se non una cabala, a causa della sua ascientificità e del cieco empirismo con cui, di conseguenza, viene determinata.
7.6.2. Il criterio di liquidazione basato sulla percentuale di "incapacità lavorativa specifica", in secondo luogo, è erroneo perché la riduzione della capacità di svolgere un lavoro non può misurarsi in punti percentuali, sicché il relativo "calcolo" manca del più importante presupposto: la scientificità.
In punti percentuali si può misurare l'invalidità biologica, non l'incapacità di lavoro. Solo la prima infatti è identica per soggetti della stessa età, dello stesso sesso e con identici postumi.
La capacità di lavoro invece è soggettiva e varia a seconda del tipo di lavoro svolto dalla vittima, come da tempo messo in evidenza dalla stessa dottrina medico legale, secondo la quale la capacità specifica è parametro a tal punto personalizzato ed individuale da rifuggire inquadramenti numerici, necessariamente limitativi ed imprecisi nella delineazione di un concetto cui può ritenersi estraneo ogni schematismo.
7.6.3. In terzo luogo qualsiasi misurazione (percentuale o di altro tipo) esige che si disponga d'una unità di misura: ma non esiste alcun barème medico legale dal quale ricavare la percentuale di riduzione di capacità di lavoro.
Il danno biologico si può misurare in punti percentuali perché esso esprime la riduzione della capacità di svolgere le attività quotidiane ed ordinarie (camminare, leggere, curare la propria persona, ecc.), e le attività quotidiane sono uguali per tutti. Questo rende possibile, sulla base dell'osservazione dei casi analoghi, redigere una tabella delle percentuali di menomazione collegate ad ogni singola invalidità.
L'incapacità lavorativa invece non può misurarsi in punti percentuali perché non disponiamo di un barème, né un barème delle incapacità lavorative
potrebbe concepirsi, per l'infinità varietà delle attività lavorative in cui può impegnarsi un essere umano, e le altrettanto infinite modalità con cui il medesimo lavoro può essere svolto da persone diverse.
7.7. Sotto il secondo profilo, pretendere che il danno da lucro cessante debba ritenersi dimostrato sol perché sia stata apprezzata dal medico legale una certa misura percentuale di "incapacità lavorativa specifica" è affermazione giuridicamente erronea, in quanto l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica esprime solo la possibilità del danno, non la sua certezza e tanto meno la sua probabilità, e non comporta perciò l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante (ex multis, Cass. Sez. 3, 03/07/2014, n. 15238).
7.7.1. Tale ultima questione, come accennato, ha fatto registrare in passato oscillazioni nella giurisprudenza di questa Corte. Oscillazioni còlte dalla ricorrente che, poco lodevolmente, trascelte le sole decisioni a sé favorevoli e ignorando le restanti di diverso avviso, le ha invocate a sostegno della propria impugnazione.
7.7.2. Secondo un primo orientamento, infatti, il nesso di causalità tra postumi e riduzione della capacità di lavoro e di guadagno non può ritenersi automatico.
Così come lesioni gravi potrebbero provocare riduzioni minime del reddito, per contro anche postumi permanenti minimi potrebbero incidere sulla capacità di svolgere determinati lavori. Perciò spetta al giudice valutarne in concreto e caso per caso l'incidenza (Cass. civ., sez. III, ord. 3.9.2024 n. 23553; Cass. civ., sez. III, 17.5.2022 n. 15735; Cass. civ., sez. III, ord. 22.8.2018 n. 20918; Cass. civ., sez. III, 12.2.2015, n. 2758; Cass. civ., sez. III, 12.2.2013, n. 3290; Cass., sez. III, 18.9.2007, n. 19357; Cass., sez. III, 8.8.2007, n. 17397; Cass., sez. III, 14.6.2007, n. 13953; Cass., sez. III, 20.1.2006, n. 1120).
7.7.3. Un secondo orientamento, invece, pur affermando a livello teorico che l'esistenza del nesso di causalità tra lesioni e riduzione della capacità lavorativa debba essere concretamente dimostrata, in concreto ritiene che tale prova possa essere desunta ex art 2727 c.c. dal solo fatto che il grado di invalidità biologica sia superiore ad una certa soglia.
Secondo questo orientamento nel caso di postumi permanenti anche solo di media gravità sarebbe consentito presumere (ex art. 2727 c.c.) che essi sicuramente incideranno sulla capacità di lavoro del danneggiato. Questo orientamento tuttavia è sommamente eterogeneo nel fissare la "soglia" oltre la quale l'entità dei postumi permanenti dovrebbe far presumere ex art. 2727 c.c. la sussistenza d'un danno alla capacità di guadagno. Alcune decisioni hanno individuato la misura del danno biologico permanente, oltre la quale "deve" presumersi l'incidenza sulla capacità di lavoro, nel 10% (Cass. civ., sez. III, 25.9.1997 n. 9399); altre nel 25% (Cass. civ., sez. III, 7.11.2005 n. 21497); altre ancora nel 30% (Cass. civ., sez. III, 28.6.2019 n. 17411).
7.8. Reputa il Collegio che questo secondo orientamento non possa essere condiviso.
L'infinità varietà delle persone, dei lavori da esse svolti e dei postumi permanenti che possono residuare ad un infortunio fanno della decisione sull'esistenza del danno da lucro cessante un giudizio sintetico a posteriori, non un giudizio analitico a priori.
E' dall'accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla prova del danno ed alla sua causa; non è invece corretto, una volta ritenuta in astratto l' "incapacità lavorativa" della vittima, desumerne la prova d'una contrazione patrimoniale, senza nessun accertamento in concreto d'una deminutio patrimonii.
Questo principio, oltre che imposto dagli artt. 1223 e 2056 c.c., è stato indicato come il criterio preferibile di liquidazione del danno anche dall' "Allegato" (Annexe) alla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa 14.3.1975, n. 75-7. Tale risoluzione, con l'intento di attenuare le divergenze di leggi e prassi tra i Paesi aderenti alla CEDU (così si legge nel preambolo), ha raccomandato agli Stati membri di "prendere in considerazione", allorché adottino nuove legislazioni sul tema dei danni alla persona, i princìpi contenuti nel suddetto "Annexe".
Ebbene, il par. II, punto 6, dell'Annexe raccomanda che nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro si tenga conto "dei redditi della vittima posteriori al sinistro, comparati con quelli che avrebbe ottenuto se il fatto dannoso non si fosse verificato" ("il doit ètre tenu compte de ses revenus (scilicet, della vittima, n.d.e.) après l'accident comparés à ceux qu'elle aurait obtenus si le fait dommageable ne s'était pas produit"), così confermando che la stima del danno in esame va compiuta in concreto, e non in base ad una astratta ed inafferrabile percentuale di "incapacità lavorativa specifica".
7.8.1. L'incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro andrà dunque valutata in base a tre passaggi: a) l'accertamento dei postumi; b) l'accertamento della compatibilità tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale, richiesta dal lavoro svolto dalla vittima; c) l'esistenza in atto od in potenza d'una riduzione patrimoniale.
Naturalmente questo giudizio ha per corollario che il danneggiato alleghi e provi il tipo di lavoro svolto, il tipo di mansioni corrispondenti, il tipo di impegno fisico o psichico da esse richiesto. Dimostrato ciò, il Giudice per la stima del danno in esame potrà ricorrere ovviamente anche alla prova presuntiva, che tuttavia dovrà basarsi su fatti noti dai quali risalire ai fatti ignorati, e non sul mero automatismo tra entità dei postumi e sussistenza del danno.
7.9. Alla luce di quanto esposto deve rigettarsi la censura qui in esame, nella parte in cui sostiene che, avendo "accertato" il medico legale una "incapacità lavorativa specifica" del 25% (numero, per quanto detto, che dal punto di vista giuridico non corrisponde ad una ponderata stima basata su controllabili
criteri di scientificità), dovrebbe presumersi ipso facto una pari riduzione del reddito.
7.10. Deve invece accogliersi la censura qui in esame nella parte in cui ascrive alla sentenza impugnata di avere del tutto omesso di accertare se i postumi obiettivamente accertati fossero o meno compatibili, in tutto od in parte, con la prosecuzione dell'attività lavorativa svolta dalla vittima prima dell'infortunio.
La sentenza impugnata, infatti:
ha accertato in punto di fatto che la vittima ha perso il lavoro e quindi il reddito;
ha accertato in punto di fatto che la vittima ha postumi invalidanti che compromettono l'articolarità della spalla sinistra;
ha tuttavia rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro
lavorativa generica della danneggiata, intesa come chance di trovare un'occupazione e uno sviluppo di carriera anche diversa da quella che svolgeva al momento del sinistro".
8.1. La censura è inammissibile.
La Corte d'Appello (p. 16, terzo capoverso) ha liquidato il danno patrimoniale in misura pari alla nretribuzione che la sig.ra Me.Ja.cessante futuro, sul presupposto che la vittima non avrebbe dimostrato di avere cercato un lavoro che fosse in grado di garantirle "un reddito pari" a quello precedentemente percepito.
Tale statuizione viola gli artt. 1223 e 1226 c.c. sotto più profili. In primo luogo, il danno da perdita del reddito può essere totale o parziale. La vittima d'un infortunio può perdere il reddito del tutto, oppure può essere costretta a lavorare meno, e guadagnare in proporzione. Dunque è scorretto esigere dalla vittima la prova di non potere trovare un lavoro che garantisca "un reddito pari" a quello perduto.
In secondo luogo, la liquidazione del danno da lucro cessante futuro è largamente equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c.. Essa deve tenere conto non solo di quel che è accaduto, ma anche di quel che presumibilmente potrà accadere. Dunque l'accertamento dell'esistenza del danno da perdita del reddito futuro, sia totale che parziale, avrebbe dovuto tenere conto delle peculiarità del caso concretamente dimostrate o non contestate: l'età della vittima, le condizioni del mercato del lavoro, la compatibilità tra i postumi e la gestualità richiesta dal lavoro precedentemente svolto.
7.11. In conclusione, la censura qui in esame deve essere parzialmente accolta in applicazione dei seguenti princìpi di diritto:
"L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire: a) accertando l'entità dei postumi permanenti; b) accertando la compatibilità tra i postumi e l'impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima; c) valutando se l'eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale. Deve invece escludersi che gli accertamenti suddetti possano compiersi in abstracto, chiedendo al medico-legale di quantificare in punti percentuali la c.d. "incapacità lavorativa specifica", e moltiplicando il reddito perduto per la suddetta percentuale".
"Sebbene il danno da lucro cessante causato dall'incapacità di lavoro possa dimostrarsi anche col ricorso alle presunzioni semplici, deve escludersi ogni automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del suddetto danno".
"La circostanza che la vittima di lesioni personali, licenziata a causa del superamento del periodo di comporto, non dimostri di avere cercato un altro lavoro che le garantisse un pari livello di reddito non è di per sé d'ostacolo alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante".
8. Sulla "perdita di chance".
A p. 13 del ricorso la ricorrente formula una quarta censura, con la quale denuncia la violazione del principio di integralità del risarcimento. Lamenta che erroneamente la Corte d'Appello avrebbe "omesso di riconoscere il risarcimento della lesione della capacità avrebbe percepito in un periodo che le sarebbe stato ragionevolmente necessario per trovare una nuova occupazione, qualora ella si fosse attivata diligentemente nella ricerca dello stesso".
Così giudicando, la Corte territoriale ha mostrato implicitamente di ritenere che non fosse precluso alla vittima di trovare una nuova occupazione. Dunque la Corte d'Appello non ha affatto negato la risarcibilità in astratto d'un danno da perdita delle chance di trovare un nuovo lavoro; semplicemente ha ritenuto che nessuna chance la vittima avesse perduto. Valutazione la quale, giusta o sbagliata che fosse, costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
9. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1227 c.c. (così a p. 17; si prescinde dalla intitolazione del motivo). L'illustrazione del motivo è così concepita:
dopo avere trascritto parte della motivazione della sentenza impugnata, la ricorrente esordisce affermando non esservi in atti "alcun elemento, né è stata fornita alcuna tempestiva allegazione, in merito al fatto che la (danneggiata) abbia colpevolmente omesso di attivarsi per la ricerca" di una nuova occupazione;
seguono varie deduzioni sul fatto che una persona non più giovane, straniera, con scarsa conoscenza della lingua italiana, difficilmente potrebbe trovare una nuova occupazione;
quindi viene trascritta ampia parte d'una motivazione di questa Corte, ove si afferma il principio che è onere del convenuto dimostrare che la vittima d'un danno alla salute, pur avendo perso il lavoro, avrebbe potuto trovarne un altro, e non lo fece.
9.1. La farragine con cui è esposta la censura (un collage di passi estrapolati dall'atto d'appello, da sentenze di legittimità e dalla comparsa conclusionale d'appello) ne rende malagevole la qualificazione.
Il Collegio, dopo molte letture e nel rispetto del principio dell'interpretazione utile, ritiene che l'unica interpretazione possibile di questa parte del ricorso sia supporre che, con essa, la ricorrente abbia inteso censurare la sentenza impugnata per averle addossato l'onere della prova di essersi inutilmente attivata per cercare un lavoro, in luogo di addossare ai convenuti l'onere di provare il contrario.
9.2. La ricorrente è nel vero quando assume che l'onere di provare l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. grava su chi la solleva.
Infatti la negligente condotta del danneggiato che, perduta l'occupazione a causa dell'infortunio, non si attivi per impiegare le proprie residue forze industri in un nuovo lavoro è fatto costitutivo dell'eccezione di aggravamento colposo del danno (art. 1227, secondo comma, c.c.), non fatto costitutivo della domanda di danno. Spetterebbe dunque al debitore provare che la vittima, pur potendo trovare con ragionevole probabilità di successo un nuovo lavoro, non lo cercò.
Tuttavia tale doglianza è inammissibile per la sua novità. Nell'atto d'appello infatti la ricorrente censurò la sentenza di primo grado per avere rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ma senza nulla osservare circa l'interpretazione e/o la violazione dell'art. 1227, secondo comma, c.c., e il riparto dell'onere della prova.
10. Il terzo motivo.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, nel regolare le spese del primo grado di giudizio, le abbia liquidate in misura inferiore a quanto ritenuto dal Tribunale, pur in assenza di impugnazione incidentale da parte della UnipolSai.
3.1. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento della seconda e della terza censura di cui al primo motivo di ricorso.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione; dichiara inammissibile il secondo motivo; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 18 marzo 2025.
Depositata in cancelleria il 20 giugno 2025.