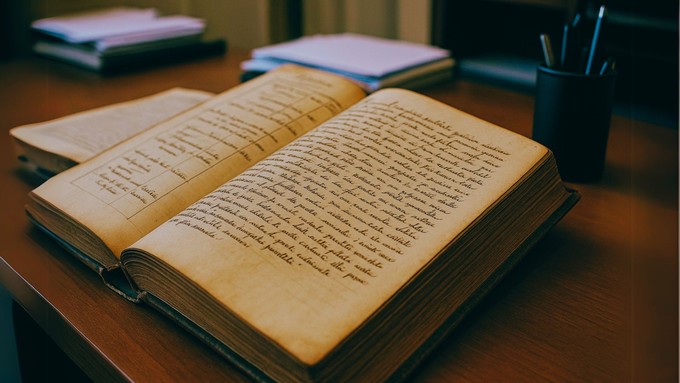
Il presente contributo analizza la disciplina degli usi civici in Lombardia alla luce del nuovo regolamento regionale approvato con DGR n. 4192 del 15 aprile 2025. Dopo una ricostruzione dell’evoluzione storica e normativa dell’istituto, dalle origini consuetudinarie fino alla recente valorizzazione operata dalla legge n. 168/2017, l’articolo esamina l’impatto della giurisprudenza costituzionale sulla legislazione regionale lombarda, culminata con l’abrogazione delle precedenti norme di favore per la liberalizzazione fondiaria. Il nuovo regolamento, attuativo della legge regionale n. 31/2008, si distingue per un impianto organico e innovativo, che pone al centro la tutela ambientale, il rafforzamento del ruolo della Soprintendenza, la partecipazione delle comunità locali e il coinvolgimento degli enti esponenziali. In conclusione, si evidenzia come gli usi civici, da istituto arcaico, si stiano progressivamente trasformando in uno strumento giuridico moderno, capace di coniugare la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità con le esigenze di sviluppo sostenibile dei territori.
** * **
Gli Usi Civici in Lombardia: Analisi del Nuovo Regolamento Regionale
Sommario: 1. Inquadramento Generale degli Usi Civici in Italia; 2. Riattualizzazione degli Usi Civici Dopo la Legge n. 168/2017; 3. La Giurisprudenza Costituzionale e l'Abrogazione degli Articoli sugli Usi Civici della Legge Regionale Lombarda; 4. Analisi del Nuovo Regolamento Regionale Lombardo in Materia di Usi Civici; 5. Conclusioni: Gli Usi Civici, Strumento Dinamico per la Sostenibilità Territoriale.
1. Inquadramento Generale degli Usi Civici in Italia
Gli usi civici rappresentano un istituto giuridico di vetusta origine, le cui radici affondano in contesti sociali ed economici pre-moderni, segnatamente di epoca feudale, ma che hanno dimostrato una notevole resilienza all'evoluzione storica e culturale del Paese. La loro persistenza nel tessuto giuridico italiano, pur con le necessarie riletture e adattamenti, testimonia la capacità di tali istituti di rispondere a esigenze sociali perduranti, legate alla gestione collettiva delle risorse naturali[2].
Come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 5409/2024), la genesi della maggior parte di questi diritti è storicamente legata a consuetudini e comportamenti di fatto, spesso consolidatisi nel tempo senza l'adozione di atti formali idonei a conferire pubblicità al fenomeno. Ciò ha comportato, in molti casi, difficoltà di ricostruzione e delimitazione precisa dei diritti stessi, nonché incertezze interpretative sulla loro attuale operatività[3].
All'interno della categoria degli usi civici, si distinguono tradizionalmente due figure principali:
- Usi civici in senso stretto: configurabili come diritti reali di godimento in re aliena su beni appartenenti a soggetti pubblici o privati. Tali diritti attribuiscono a una collettività determinata la facoltà di utilizzare il fondo per specifiche utilità (es. pascolo, legnatico, caccia, pesca), comprimendo in tal modo il diritto di proprietà del titolare del fondo.
- Domini collettivi: intesi quali forme di proprietà collettiva o comproprietà indivisa di terre spettanti ad una collettività ben individuata di soggetti (universitas hominum) mediante un godimento promiscuo. In questo caso, la collettività è titolare del diritto di proprietà sul bene, esercitando su di esso poteri di gestione e disposizione.
La disciplina fondamentale degli usi civici è stata inizialmente delineata dalla legge n. 1766/1927 e dal regio decreto n. 332/1928 (Regolamento per l'applicazione della legge). Tale normativa, pur rappresentando un importante tentativo di sistemazione organica della materia, ha trovato una scarsa applicazione nell'ordinamento repubblicano. Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, ciò è stato dovuto, in parte, al contrasto con il principio della divisione dei poteri e alla commistione di funzioni amministrative e giurisdizionali che caratterizzava la figura del Commissario per la liquidazione degli usi civici, organo cui era affidata l'attuazione della legge[4].
2. Riattualizzazione degli Usi Civici Dopo la Legge n. 168/2017
La legge n. 168/2017, recante “Norme in materia di domini collettivi”, ha segnato una svolta fondamentale nella disciplina degli usi civici, introducendo una nuova visione e una rinnovata valorizzazione dei "domini collettivi". Come evidenziato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 12571/2023), la nuova normativa ha determinato una profonda trasformazione nella concezione degli usi civici, che devono ora operare "in assoluta sinergia con la tutela paesistico-ambientale"[5].
I domini collettivi vengono qualificati dalla legge come "ordinamento giuridico primario delle comunità originarie" e sono riconosciuti come un istituto che attua i principi costituzionali di cui agli articoli 2 (tutela dei diritti inviolabili dell'uomo) e 9 (tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione) della Costituzione, nonché gli articoli 42, comma 2 (funzione sociale della proprietà), e 43 (socializzazione di determinate imprese) della Carta fondamentale[6]. La legge n. 168/2017 ha rafforzato significativamente il regime di tutela dei beni di uso civico collettivo, prevedendone espressamente l'inalienabilità, l'indisponibilità e l'inusucapibilità[7].
Significative modifiche alla disciplina sono state successivamente introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), il cui articolo 63-bis ha aggiunto all'articolo 3 della legge n. 168/2017 nuove disposizioni relative ai trasferimenti di diritti di uso civico e alle permute, subordinandole a specifiche condizioni e garanzie, volte a contemperare le esigenze di valorizzazione economica dei beni con la salvaguardia dei valori ambientali e culturali ad essi connessi.
3. La Giurisprudenza Costituzionale e l'Abrogazione degli Articoli sugli Usi Civici della Legge Regionale lombarda
La recente evoluzione normativa in Lombardia è stata fortemente influenzata dalla giurisprudenza costituzionale, che ha progressivamente delineato i limiti della competenza legislativa regionale in materia di usi civici. Come evidenziato dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Brescia nella sentenza n. 236/2023, la Regione Lombardia ha dovuto modificare radicalmente il proprio approccio alla materia, passando "da una normativa ispirata da una posizione di disfavore verso gli assetti fondiari collettivi"[8] a disposizioni orientate alla "prevalente esigenza di salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e culturale del Paese"[9].
La nuova legge regionale n. 33/2022 ha assoggettato le aree gravate da usi civici al regime vincolistico e conservativo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), riconoscendone la valenza paesistica e ambientale[10]. Significativamente, la normativa ha abrogato il previgente istituto dello sgravio dall'uso civico di cui all'articolo 167 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, prevedendo l'improcedibilità dei procedimenti in corso relativi a richieste di alienazioni, mutamenti di destinazione, scioglimento delle promiscuità, liquidazioni, legittimazioni e regolarizzazioni.
Tale modifica normativa si è resa necessaria per allineare la legislazione regionale ai principi costituzionali e alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.). La Corte Costituzionale, in diverse pronunce, ha infatti ribadito che la disciplina degli usi civici, in quanto incidente su valori paesaggistici e ambientali di rilevanza nazionale, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, limitando gli spazi di intervento delle Regioni alla sola disciplina delle modalità di esercizio dei diritti. In seguito alla modifica dall’art. 165 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 che titola “completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici, rinvio alle disposizioni del Titolo I, Parte terza, del d.lgs. 42/2004 e all’adozione di un regolamento su aspetti procedurali” e all’abrogazione degli artt. da 168 a 175 si delinea il nuovo assetto normativo della Regione Lombardia che vede il pieno compimento con la pubblicazione del Regolamento regionale n. 4192 del 15/04/2025.
4. Analisi del Nuovo Regolamento Regionale Lombardo in Materia di Usi Civici
Il regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 4192 del 15/04/2025 rappresenta un importante tassello nel processo di riordino della materia degli usi civici in Lombardia, dando attuazione al Titolo XI della legge regionale n. 31/2008. Il regolamento si caratterizza per alcuni elementi innovativi e di particolare interesse, che ne qualificano l'impianto complessivo.
4.1 Struttura e Ambito di Applicazione
Il regolamento disciplina in modo organico e dettagliato le procedure amministrative relative a una serie di istituti afferenti agli usi civici, tra cui:
- Alienazione di terreni gravati da usi civici
- Liquidazione dei diritti d'uso civico
- Scioglimento di promiscuità
- Mutamento temporaneo di destinazione d'uso
- Legittimazione dell'occupazione senza titolo
- Reintegra
- Trasferimento di diritti di uso civico e permuta
Tale organicità risponde all'esigenza di certezza del diritto e di semplificazione delle procedure, fornendo agli enti locali e ai privati un quadro normativo chiaro e completo per la gestione delle problematiche inerenti agli usi civici.
4.2 Elementi Innovativi
Tra gli aspetti più rilevanti del regolamento, si segnalano:
a) Rafforzamento del ruolo della Soprintendenza: il regolamento prevede sistematicamente il parere vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio per tutte le procedure, in considerazione della rilevanza paesaggistica e culturale dei beni gravati da usi civici. Il termine per il rilascio del parere è fissato in 90 giorni. È prevista una procedura di diffida in caso di inerzia, con un termine ulteriore di 10 giorni, decorso il quale la struttura competente può comunque provvedere.
b) Valorizzazione della partecipazione: al fine di garantire la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il regolamento prevede la pubblicazione all'albo pretorio del comune interessato per la durata di 30 giorni per ogni procedimento. Durante tale periodo, chiunque vi abbia interesse ha facoltà di presentare osservazioni alla struttura competente.
c) Ruolo degli enti esponenziali: il regolamento riconosce espressamente il ruolo degli enti esponenziali delle comunità di riferimento (ove esistenti), prevedendone il coinvolgimento nelle procedure e nella gestione dei proventi derivanti dalla valorizzazione dei beni di uso civico.
d) Tutela paesaggistica: in linea con i principi costituzionali e la giurisprudenza della Corte Costituzionale, il regolamento pone un forte accento sulla tutela paesaggistica e ambientale, prevedendo specifiche valutazioni e documentazioni a supporto delle istanze, nonché il già menzionato parere vincolante della Soprintendenza.
5. Conclusioni: Gli Usi Civici, Strumento Dinamico per la Sostenibilità Territoriale
L’analisi condotta conferma come il nuovo regolamento regionale lombardo rappresenti una svolta significativa nella disciplina degli usi civici, non soltanto sotto il profilo tecnico-giuridico, ma soprattutto per la sua capacità di reinterpretare un istituto tradizionale alla luce delle sfide contemporanee poste dalla transizione ecologica, dalla tutela del paesaggio e dalla partecipazione democratica. In tale prospettiva, gli usi civici si confermano strumenti giuridici dinamici, capaci di evolversi da realtà residuali o percepite come arcaiche verso un ruolo centrale nella pianificazione sostenibile e condivisa del territorio.
Il regolamento, attuativo del Titolo XI della legge regionale n. 31/2008, dimostra una visione chiara e strutturata, capace di superare le incertezze interpretative del passato e di offrire agli enti territoriali e ai cittadini uno strumento funzionale, trasparente e rispettoso dei principi costituzionali.
Elemento qualificante dell’intervento normativo lombardo è la capacità di integrare efficacemente i vari livelli di governo del territorio: dalla centralità attribuita alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, il cui parere vincolante garantisce una salvaguardia effettiva dei beni di rilievo ambientale e paesaggistico, alla valorizzazione degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti d’uso civico, passando per la promozione della partecipazione dei cittadini attraverso strumenti concreti di consultazione pubblica. Tale struttura conferisce al regolamento non solo un valore tecnico elevato, ma anche una significativa forza legittimante dal punto di vista democratico.
Non meno rilevante è il contributo del regolamento alla costruzione di un modello di sviluppo territoriale sostenibile, capace di tutelare risorse naturali essenziali come boschi, pascoli e aree umide, senza trascurare le esigenze di adattamento e resilienza delle comunità locali. I beni gravati da usi civici vengono così riconosciuti non solo come espressione storica di un diritto collettivo, ma come infrastrutture ecologiche essenziali nella lotta contro il cambiamento climatico, nella conservazione della biodiversità e nella valorizzazione di economie locali basate sull’uso sostenibile del territorio.
In questo quadro, la Regione Lombardia si configura come un autentico laboratorio normativo, capace di anticipare e interpretare le linee evolutive del diritto ambientale e della governance territoriale. L’esperienza lombarda mostra come un intervento regolatorio ben congegnato possa non solo rispettare i vincoli imposti dalla giurisprudenza costituzionale e dal quadro normativo nazionale, ma anche farsi promotore di nuove forme di gestione del territorio, fondate sulla cooperazione tra istituzioni, comunità e amministrazioni locali.
In definitiva, il nuovo regolamento sugli usi civici restituisce attualità a un istituto giuridico di antica origine, inserendolo con coerenza all’interno di un progetto complessivo di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale lombardo. La Lombardia, attraverso questo intervento, non si limita a colmare un vuoto normativo, ma lancia un messaggio preciso: la tradizione può diventare innovazione, se interpretata con lungimiranza e responsabilità istituzionale. L’auspicio è che tale modello possa fungere da esempio virtuoso anche per altre Regioni, contribuendo alla costruzione di un sistema territoriale più equo, resiliente e sostenibile a livello nazionale.
[1] Presidenza del Consiglio dei Ministri
[2] Per un approfondimento sul punto si vedano: F. Marinelli, Gli usi civici, Giuffrè Editore, 2013; V. Cerulli Irelli – L. De Lucia, Beni comuni e diritti collettivi, in Politica del diritto, 45/1 (2014), pp. 3–36; V. C. Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, CEDAM-Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1983
[3] M. C. Cervale, Usi civici, diritto civile e tutela del paesaggio: la nuova legge sui domini collettivi., in Rassegna di Diritto Civile/4 (2018)
[4] U. Petronio, Rileggendo la legge usi civici, in Rivista di diritto civile, 5 (2006), pp. 616–665
[5] F. Politi – F. Marinelli, Domini collettivi ed usi civici: riflessioni sulla legge n. 168 del 2017: atti del XVI Convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista G. Cervati, L’Aquila, 31 maggio 2018 (2019)
[6] W. Giulietti, Norme in materia di domini collettivi ed assetti organizzativi, in Diritto dell’economia/3 (2018), pp. 1041–1058
[7] F. Politi – F. Marinelli, Domini collettivi ed usi civici: riflessioni sulla legge n. 168 del 2017: atti del XVI Convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista G. Cervati, L’Aquila, 31 maggio 2018, cit.
[8] Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 236 del 2023
[9] Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 236 del 2023
[10] Un aspetto fondamentale della legge è l'assoggettamento delle aree gravate da usi civici al regime vincolistico e conservativo previsto dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Questo comporta che tali aree devono essere oggetto di:1. Specifica ricognizione e delimitazione nell'ambito del piano paesistico regionale; 2. Normative d'uso orientate alla loro conservazione; 3. Salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche; 4. Preventiva autorizzazione paesaggistica per gli interventi, rilasciata dalla Regione o dagli enti delegate.